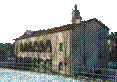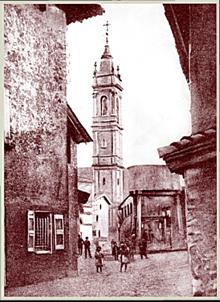Resteline, monichelle e soldà-i d’armàda

La tradizione del
canto lirico e narrativo nelle stalle e sulle aie lombarde
|
ASSOCIAZIONE PENSIONATI e ANZIANI OSIO SOPRA |
Osio Sopra |
SOTTO IL GELSO
Rievocazione contadina
“Il
granoturco nella vita
e
nella cultura di Osio Sopra”

Sabato 24 Settembre
Alla casa ad archi dalle 20,30 alle 22,30
Stall de l’Astùra
In
collaborazione con 
Un ringraziamento particolare
all’azienda agricola Dalmaggioni di via Capra per la collaborazione
Durante
la Prima festa contadina, organizzata in collaborazione con l’Associazione
Pensionati e Anziani di Osio Sopra, abbiamo eseguito le canzoni di seguito
riportate e che sono, a nostro personale avviso, sono alcune fra le canzoni più
significative di quelle che venivano cantate nelle
stalle di tutta la Lombardia.
Ói védovìna,
ói védovèlla
Partiamo
con una canzone raccolta a Tremezzo (CO)[1], “terra di mezzo” e il suo nome deriva dalla posizione
geografica centrale rispetto alla costa occidentale del Lario.
La
canzone è meglio conosciuta con il titolo “la maledizione della madre”, è stata registrata il 27 Aprile del 1975 ed è pubblicata su “Como e il suo territorio” della collana
“Mondo popolare in Lombardia” curata da Roberto Leydi.
I-ói
védovìna i-ói védovèlla
la vòstra figlia l’è di maritàr
I-ói
védovìna i-ói védovèlla
la vòstra figlia l’è di maritàr
I-aspétterémo
quàttro ó cinqu’ànni
piö grandicèlla la divénterà
I-aspétterémo
quàttro ó cinqu’ànni
piö gràndicèlla la divénterà
E
ma piötòst che dàrti la mia fìglia
ti dò la brìglia del piö bèl cavàl
piötòst che dàrti la mia fìglia
ti dò la brìglia del piö bèl cavàl
Ti dò la brìglia ti dò la sèlla
la figlia-i bèlla me la téngo mé
Ti dò la brìglia ti dò la sèlla
la figlia-i bèlla me la téngo mé
Segnatura:
LP0145RegLombDCP7/ VPA8299RL / AESS [SUP-IMP00-0000007625]
Le carrozze son già preparate
Questa
canzone è stata registrata nella frazione di Colleri del comune di Brallo di Pregola, nella zona alto-collinare agli estremi
della provincia di Pavia.
Questa
canzone, raccolta dai ricercatori Pierluigi Navoni e Bruno Pianta, è’ più nota
con il titolo “La Lena” in quanto l’ultima strofa, in
alcune versioni dice:
Giovanotti
piangete piangete
chè perduta
avete la Lena
così cara,
sì pura e sì bella
e in un
convento rinchiusa
e in un convento rinchiusa lei sta
Nella
versione di Giovanna Daffini[2],
l’ultimo versetto recita:
O
giovanotti piangete
O
giovanotti piangete con me
Il
testo ricorda molto da vicino la canzone “La domenica andando alla messa” molto
più diffusa in tutto il Nord Italia.
Ci siamo attenuti rigorosamente alla
versione del “Gruppo di Colleri.
Le
carrozze son già preparate
i cavalli son pronti a partire
dimmi ói bella se tu vuoi venire
se vuoi venir ai passeggi
se vuoi venire ai passeggi con me
Ai
passeggi ci sono già stata
compagnata dai miei amatori
se ne accorsero i miei genitori
e monachella mi fecer
e monichella mi fecero ‘ndar
Monichella
io sono già stata
m’àn rinchiusa fra muri e cancelli
m’àn tagliato i miei biondi capelli
e m’hanno tolto le mie
e m’hanno tolto le mie beltà
Il
tema della ragazza costretta dai genitori a farsi monaca, è un tema molto
ricorrente nella cultura e nella canzone popolare di tutta Europa oltre che
della Lombardia, e questa canzone ne è un bellissimo esempio.
Segnatura:
NSTLOPV006 / AESS [SUP-IMP00-0000009040]
Armelìna
Meglio
conosciuta come “Seghé l’èrba murelìna”, questa è una canzone del ricco
repertorio delle sorelle Natalina, Luigina e Franca Bettinelli di Ripalta
Cremasca in provincia di Cremona.
I
comuni di Ripalta Cremasca, Ripalta Arpina e Ripalta Guerina si trovano sul
basso corso del fiume Serio, prima che, esattamente in località Bocca di Serio
del comune di Montodine, confluisca con il Fiume Adda.
Le
sorelle Bettinelli hanno tramandato per decenni le canzoni e la cultura della
cascina cremasca, celebrate nella pubblicazione “Cremona e il
suo territorio” curata da Sandra Mantovani, della già citata collana
“Mondo popolare in Lombardia”.
La
canzone racconta di una contadina che dai campi dove sta rastrellando l’erba, viene mandata a prendere il desinare.
Sulla
strada viene fermata ed importunata da un uomo; Armelina
rifiuta il corteggiamento dell’uomo e, con un gesto inaspettato, lo uccide.
L’idea
della ragazza, apparentemente indifesa, che si fa giustizia da sola è un tema
caro alla canzone popolare.
Per
certi aspetti la melodia ricorda canzoni quali La bionda di Voghera o La belå de
Oplagå[3]
tranne appunto che per il finale a sorpresa.
Per
la verità questa stessa canzone, con il titolo di “La vivandiera assassinata”
ha un finale opposto secondo il quale è il bellimbusto che uccide la ragazza.
Nella
versione delle Bettinelli l’ultima strofa non lascia adito a dubbi e l’orgoglio
femminile si fa valere.
Seghé
l’èrba murelìna
Seghé
l’èrba ch’l’à trà ‘l bèl fiór[4]
Prenderémo
tre réstélìne, le manderémo a réstelàr (2)
Scéglierémo
la più-i bèlla, ma la più-i bèella
La
manderémo a purtà ‘l disnà
Scéglierémo
la più bèlla
la manderémo a purtà ‘l disnà
Quan
fui stato metà ‘lla strada, metà ‘lla strada
La
gh’à incontrato ‘l suo primo amór[5]
Quan
fui stato metà ‘lla strada
la gh’à incontrato ‘l suo primo amór
Dove
vai o Armélìna, o Armélina
Vò
a fòra purtà ‘l disnà
O
mètti giù quèl péntolìno e sótto l’ómbra farè ll’amór
Fàr l’amóre io non c’ò témpo, Io non ci’
ò témpo
Dévo
andàre purtà ‘l disnà
A
fàr l’amóre io non c’ò témpo
dévo andàre purtà ‘l disnà
La
tìra fòra ‘l curtèl de tàsca, curtèl de tàsca
E
nel cuòre gliéla gettò
La
tira fòra ‘l curtèl de tàsca
e nel cuòre gliéla gettò
Còsa
fai o Armélìna, o Armélìina
Che
ài ucìso ‘l tuo primo amór
Còsa
fai o Armélì_ina che ài ucìso il tuo primo amór
Nella
nostra zona si canta una canzone molto simile a questa:
Sighesì che ‘l
taja l’erba
taja
l’èrba ‘n mès al prà
Restelì che i-a restèla
i-a
restèla ancor più bén
Metti giù quel cestolino
sotto
l’ombra farem l’amòr
Far l’amore si va in campagna
Sotto l’ombra ma di un bel fiòr
Ma
il testo è quanto mai incerto e abbiamo preferito ripegare sulla versione,
sicuramente originale, delle sorelle Bettinelli.
Segnatura:
Misc.MPL.7 / AESS
[SUP-IMP00-0000007738]
La rondine importuna
Come
tutte le canzoni popolari, anche questa è più nota con il suo incipit “Peppino
entra in camera”.
Una
bellissima esecuzione è stata effettuata il 14/09/1977
da Brignoli Vittorio e registrata dai ricercatori bergamaschi Sandra e Mimmo
Boninelli durante una ricerca da loro effettuata a Torre de Roveri.
I nastri originali
sono conservati presso la Biblioteca Antonio Tiraboschi - Archivio della
Cultura di Base.
Peppino
entra in camera
in camera della signora
e l’à trovada in letto
ché la dormiva sola
Era
discoperta
dal capo fino al fondo
non ho mai visto al mondo
na donna così bella
Peppino
le dà un bacio
e lei non lo sentiva
Peppino
gliene dà un altro
aimè che son tradita
Tu
non sarai tradita
sarai la sposa mia
Padrona
del castèlo
e della vita mia
Rondinella
ói bella
tu sei la traditora
tu ài cantà stanotte
prima
della tua ora
Segnatura:
CD0052FondoTiraboschi/Boninelli06 / AESS [SUP-IMP00-0000010068]
Son qui sotto le tue finestre
Con
il titolo originale “Il mio cuore ai forestieri”, la prima registrazione di
questa canzone è stata effettuata dal Gruppo di
Bienno, in “ricerca a Bienno” effettuata da Bruno Pianta nella pubblicazione
“Brescia e il suo territorio”.
Il
comune di Bienno è situato al centro della “valle dei magli”, in Valcamonica ed
è rinomato in tutta l’alta Italia per la “Ferrarezza”, l’estrazione e la
forgiatura del ferro.
Il
nome Bienno pare significhi “torrente delle miniere” e
il torrente in questione è il Grigna, affluente, poco più a valle, dell’Oglio
Durante
la Sagra-Mercato organizzata tutti gli anni dalla pro-lco e dai volontari del
paese, è possibile vedere in funzione i vecchi magli, azionati dagli anziani
del paese e i vecchi mulini, rispolverati e messi a nuovo per l’occasione.
Mulini
e magli sono mossi, come dicevamo, dal torrente Grigna che lambisce il
territorio del comune.
Son
qui sotto le tue finestre
attaccato alle inferriate
Io
non voglio tornare a casa
finchè ho fatto l’amor con te
Ma l’è inutile che tu passeggi
e tu rompi le scarpe invano
Hai
la faccia ma di un villano
il mio cuore non è per tè
Il
mio cuore non è più mio
l’ho donato ai forestieri
Giovanotti
del mio paese
io vi lascio la libertà
Segnatura:
NSTLOBS010 / AESS [SUP-IMP00-0000009028]
La figlia del paisàn
Il comune di Plesio, in provincia di Como, è uno
dei comuni in cui meglio si è conservata la tradizione dei canti e delle
ballate delle colline che circondano il lago di Como.
Risalendo la sponda occidentale del lago,
all’altezza di Menaggio, si incontra la deviazione che
porta al comune di Plesio, poco più di 800 anime.
Da lì, bricòla
in spalla, partivano i contrabbandieri diretti verso la Svizzera. Niente da
stupirsi se, in un luogo così impervio e difficilmente raggiungibile, si siano
mantenute fino ai nostri giorni, tradizioni antichissime[6].
A Plesio, nel ‘75, per la pubblicazione “Como e
il suo territorio”, è stata registrata una bella versione de “La filglia del paisàn”.
I contrabbandieri non viaggiavano mai in gruppo:
si distanziavano almeno di un centinaio di metri e, per non perdere il contatto,
cantavano sottovoce canzoni narrative lunghissime.
Se un contrabbandiere smetteva di cantare, era
un brutto segnale per tutti i suoi compagni che si mettevano immediatamente in
allerta.
La canzone si è trasferita dal repertorio della
frontiera direttamente al repertorio della stalla di cui ancora oggi è ricco il paese di Plesio.
Il testo integrale della canzone si compone infatti di una dozzina di strofe; nella nostra esecuzione,
vengono cantate le prime tre.
E
l’è la figlia d’un paisàn
lé l’è la figlia d’un paisàn
e tücc i disen che l’e bèla
E
se l’è bèla coma i dìss
e se l’è bèla coma i dìss
noi la faremo remirare
E
la faremo remiràr
noi la faremo remiràr
sì ma de trì solda-i d’armada
La canzone prosegue raccontando che il soldato
più bello rapisce la raggazza e la tiene rinchiusa per sette anni in un castello
della Francia finchè la ragazza cede alle lusinghe del soldato.
Chelo piö belo de sti tre
chelo piö belo de sti tre
a l’è stacc quel che l’à
robada
E ‘ll’à portàda de
luntan
e ‘ll’à portàda de luntan
in un castèlo de la Franza
E ‘ll’à lasàda là sètt
agn
e ‘ll’à lasàda là sètt
agn
sensa vedér né sol né lüna
E ala fì de sti sètt agn
E ala fì de sti sétt agn
El s’è dervì ‘na
finestrèla
Nella tradizione popolare si trovano parecchie
versioni di questa canzone[7]
e la caratteristica che le accomuna è la lunghezza del
testo e la durata dell’esecuzione.
I lavori di manutenzione, così come le attività
di scartocciature e sgranatura delle pannocchie, piuttosto che operazione di separare
il grano dalla pula[8], erano
attività non faticose ma lunghe e ripetitive.
Segnatura:
LP0145RegLombDCP7/ VPA8299RL / AESS [SUP-IMP00-0000007625]
Fiore messicano
Nella pubblicazione “Piamontesi mandìm a casa –
Il canto tradizionale a Dossena” Valter Biella e Francesco Zani hanno raccolto
e documentato questa canzone, più nota con il verso iniziale di “Passa e
ripassa”.
La canzone narra di un ricco cavaliere che,
venuto a sapere che la sua innamorata è morta, in preda alla disperazione, si
uccide con un pugnale sulla tomba di lei..
Dossena è un piccolo paese della Val Brembana
sopra San Pellegrino Terme. Per secoli, la gente di Dossena ha lavorato nelle
miniere in condizioni assolutamente precarie, con una mortalità altissima per
silicosi.
Chiuse le miniere gli
abitanti hanno conosciuto periodi molto difficilie seguiti dall’amarezza
dell’emigrazione, in Svizzera, Francia, Germania e Belgio.
Hanno però mantenuto uno stretto legame con i
loro luoghi e con le loro tradizioni, grazie soprattutto ad
una famiglia, la famiglia Zani, che ha tenuto alto l’orgoglio e vive le
tradizioni della gente di Dossena.
Passa
e ripassa, sotto finestre chiuse
Finestre
sempre chiuse della mia innemorata
E
finalmente, s’affaccia la sua mamma
Quella
che voi cercate l’è morta e sotterata
Gira
i cavalli, vado dal sagrestano
Vorrei
che mi insegnasse la tomba del mio amore
Guarda
là in fondo, dove la terra è mossa
Là
troverai la fossa della tua innemorata
Quando
era viva, la mi sembrava un fiore
Un
fiore messicano per me sei troppo lontano
Prendi
il pugnale, gettalo nel cuor mio
Voglio
morir anch’io al fianco del mio amore
Valter Biella è una delle figure dominanti
della ricerca nel campo della musica popolare
bergamasca e non solo.
E’ un grande sostenitore e propositore della
tradizione campanare delle valli oltre che essere un documentatissimo costruttore
e suonatore di baghèt una sorta di cornamusa
la cui diffusione in terra bergamasca è largamente documentata dagli afffreschi
presenti nelle chiese della Valle Seriana.
Guarda là quella chiusa finestra
In alta
Valsassina, dopo Taceno, Margno e Somandino, la strada scollina in Val Varrone,
una valle strettissima che parte da Premana e, passando da Pagnona e Premenico,
scende fino al lago di Como, sulla sponda lecchese, all’altezza della cittadina
di Dervio.
Premana era
nota già dal tempo degli antichi romani che vi si recavano per rifornirsi di
lance, spade e corazze costruite sfruttando le numerose miniere della zona.
Ancora oggi
Premana è una delle capitali europee delle forbici che vengono
perlopiù fabbricate da piccole officine a conduzione familiare, ricavate nei
garage e negli scantinati.
Pur essendo a
pochissimi chilometri in linea d’aria da Morbegno, non è mai stato realizzato
il passo che da Premana portasse in Valtellina per cui Premana e i paese limitrofi si trovano in una zona difficilmente
accessibile.
Grazie a
questa difficoltà si sono mantenute integre molte tradizioni
e un particolare gusto per il canto corale cui gli abitanti sono
particolarmente sensibili.
I cori
tradizionali di Premana vengono detti “Canti a tìir” ed è probabilmente dovuto
al fatto che uno dei cantori, molto più spesso una cantora, lancia in la
melodia che trascina e coinvolge il resto dei coristi.
Una grande
prova di questa tecnica è fornita tutti gli anni, la sera del 5 di Gennaio,
vigilia dell’Epifania: tutta la gente si riversa per le stradine e le piazze del
paese per la processione che chiamano “La cavalcata dei Re”, celebrazione
dell’arrivo dei Magi a Betlemme, e intonano fortissimo la “canzone dei tre re”
fra le alte case e le anguste piazzette del centro storico.
Guarda
là quella chiusa finestra
Dove
riposa l’amato mio béne
Dove
riposa l’amato mio béne
Dove
riposa l’amato mi bén
Dormi
dormi, o angiol beato
E
fa di un sonno che sia giocondo
E
fa di un sonno che sia giocondo
Come
l’amore che nutro per te
La canzone è
stata raccolta a Premana dai ricercatori Glauco Sanga e Pietro Sassu.
Informatori:
Cantori di Premana.
Efrem Gianola
presidente della Proloco di Premana e gestore del museo etnografico di Premana,
a queste due strofe ne aggiunge una terza la cui
autenticità però è abbastanza dubbia.
Guarda
là su quei prati fioriti
dove ci sono le piante seccate
come faranno di nuovo a fiorìr
Dammi un riccio dei tuoi capelli
"Dammi
un riccio" compare, come strofa interna, nella "Canzoncina di un
innamorato" pubblicata su un foglio volante stampato a Torino nel 1892
dalla tipografia operaia di Via Massena, 5.
Dopo questa
prima pubblicazione, la canzone è entrata a pieno titolo a far parte integrante
del repertorio dei cori alpini.
La versione
cui noi facciamo riferimento è quella raccolta a
Ranica (Bg) Valle Seriana, dal repertorio di Aquilina Conti "Ricerca a
scanzorosciate, Nese e Ranica.
L’andamento
melodico si è modificato pian piano, prova dopo prova, sulla base del ricordo
di come veniva cantata questa canzone nella nostra
zona.
Dammi
un riccio dei tuoi capelli
Che
io li tengo per tua memoria
Quando
sarò sul campo della vittoria
i tuoi capelli sì sì li bacerò
I
tuoi capelli son ricci e belli
sono legati a fili d’oro
Angelo
del cuor mio per te io muoio
Angelo
del cuor mio per te io morirò

Tutti i brani appartengono alla tradizione popolare e gli
arrangiamenti originali sono di GianPietro
Bacis.
IL GRANOTURCO
Origine e diffusione.
Il mais (o granturco, granone,
frumentone, melgotto ecc.) fu conosciuto dagli europei un mese dopo la scoperta
dell'America.
Zea Mais, propriamente detto, è una pianta annuale delle graminacee,
originaria dell' America Centromeridionale ed era coltivata
da Aztechi, Maya e Incas, grandi coltivazioni erano inoltre presenti a Cuba.
La
prima, rapida diffusione del mais in Europa si ebbe
nel 1600 nelle regioni Balcaniche, allora facenti parte dell'impero Ottomano,
grazie alle condizioni climatiche favorevoli che assicuravano produzioni di
granella più che doppie rispetto ai cereali tradizionali.
Qualche tempo dopo il mais iniziò a
diffondersi in Italia, probabilmente con varietà provenienti dai vicini
Balcani. Da questo, probabilmente deriva il nome popolare di «granturco», a meno che non lo si voglia attribuirlo al fatto che tutte
le cose strane venivano dette turche: “cose turche”.
Da noi viene
chiamato ”mèlgòtt” in quanto ricorda
un’altra pianta già largamente diffusa, la melga o saggina, che veniva coltivata
per la fabbricazione delle scope (scùe de
mèlga).
In genere, nei campi di granoturco si
riservavano due o tre filari per la semina della saggina.
Le regioni padane, e in particolare
quelle nord-orientali, grazie al clima favorevole furono quelle che
introdussero il mais in misura insuperata.
Le
regioni italiane più intensamente maidicole (coltivate a mais) sono Veneto, Lombardia,
Piemonte e Friuli V .G.: da sole queste quattro regioni producono circa il 66%
di tutto il mais prodotto in Italia.
La coltivazione.
 La semina del granoturco avveniva in
primavera, verso la fine di marzo o lungo il mese di aprile, quando la
temperatura media del terreno raggiunge i 12°. In alcune zone veniva anticamente seminato a spaglio e appena nate le
piantine, si procedeva alla diradatura che garantiva la giusta quantità di
piantine per metro quadrato.
La semina del granoturco avveniva in
primavera, verso la fine di marzo o lungo il mese di aprile, quando la
temperatura media del terreno raggiunge i 12°. In alcune zone veniva anticamente seminato a spaglio e appena nate le
piantine, si procedeva alla diradatura che garantiva la giusta quantità di
piantine per metro quadrato.
Nella nostra zona la semina è sempre avvenuta
in filari.
Nella semina manuale, con un
punteruolo di legno detto cavicchio (caécc)
si effettua un buco nel terreno e si mette a
dimora il chicco, detto tecnicamente cariosside, ad una profondità tra i 4 e i
6 cm.
I filari distano fra
di loro dai 60 agli 80 cm e la distanza ottimale dei semi lungo i
filari, è di circa 20 cm ma, tenendo conto della fallanza (numero di piantine
che non germoglieranno), normalmente i semi vengono posti ad una distanza di 15
cm.
A circa una settimana dalla semina, dal
chicco fuoriesce la radichetta che è destinata a raggiungere la profondità di
più di un metro e assicurerà alla piantina il rifornimento di acqua.
Le altre radici, più superficiali,
garantiranno alla piantina il nutrimento. Alla radichetta, segue a distanza di
qualche giorno, la prima fogliolina (coleoptile) che sbucherà dal terreno dopo
circa 2 settimane dalla semina.
Quando le piantine raggiungono
l’altezza di 30-40 cm, si procede alle operazioni di sarchiatura e di
rincalzo.
La sarchiature, effettuata con la zappa,
rompe le zolle di terreno fra i filari a garantire, in questo modo, un maggiore
assorbimento dell’acqua.
 Dopo
la sarchiatura si procede all’operazione di rincalzo, che consiste
nell’addossare la terra alle radici delle piantine di granoturco, che tendono a
radicare anche fuori dal terreno, e prepara i solchi per facilitare lo
scorrimento dell’acqua durante le irrigazioni del periodo estivo. Durante la sarchiature e il rincalzo, vengono inoltre estirpate le
erbe infestanti che minacciano la crescita delle piantine di granoturco.
Dopo
la sarchiatura si procede all’operazione di rincalzo, che consiste
nell’addossare la terra alle radici delle piantine di granoturco, che tendono a
radicare anche fuori dal terreno, e prepara i solchi per facilitare lo
scorrimento dell’acqua durante le irrigazioni del periodo estivo. Durante la sarchiature e il rincalzo, vengono inoltre estirpate le
erbe infestanti che minacciano la crescita delle piantine di granoturco.
La piantina si sviluppa con una serie
di foglie (circa 14) disposte alternativamente da una parte e dall’altra del
fusto.
Può raggiungere l’altezza di oltre 3
metri e, sulla cima, si sviluppa il pennacchio che rappresenta l’infiorescenza
maschile della pianta.
A metà gambo, circa 6-7 foglie dalla
cima, e altrettante dalla radice, si sviluppa quella che noi chiamiamo
pannocchia ma che scientificamente si chiama spiga, e
rappresenta la parte femminile del fiore.
Le specie attualmente
coltivate nella nostra zona fanno una sola pannocchia giallo-dorata per ogni
piantina. Esistono però specie diverse che fanno più di una pannocchia per
gambo.
Il colore delle pannocchie varia da
tipo a tipo di granoturco; si parte dalle pannocchie di colore bianco, per
arrivare fino a chicchi violacei passando da tutte le tonalità di giallo,
arancio e rosso.
L’impollinazione viene
effettuata dal vento che fa cadere i semi del pennacchio sul fiore femminile
che, una volta impollinato, darà origine alla pannocchia.
Durante il periodo di maggiore siccità
si procedeva alla irrigazione dei campi di granoturco e
veniva effettuata negli orari rigidamente assegnati ad ogni singolo
appezzamento di terreno, con il sistema delle chiuse (ös-cére) distribuite lungo i fossi.
Per dirigere l’acqua verso i punti più
alti del terreno, si scavavano piccoli fossati e, per far uscire l’acqua nei
punti strategici, si sistemavano nei fossati, pezzi di tela cerata (tìla seràda).
Oltre all’irrigazione, il granoturco
non richiede altri interventi fino al momento della raccolta.
 La
raccolta delle pannocchie e del granoturco avveniva di solito in due riprese. A
metà settembre il contadino passava nel campo e coglieva le pannocchie già
mature, cioè quelle che si erano colorate di giallo paglierino; le altre, che
conservavano ancora un colore verdastro, venivano
lasciate sullo stelo ed erano raccolte in un secondo tempo; anzi durante la prima
"passata" il contadino tagliava la parte superiore del gambo, al di
sopra delle pannocchie, affinché queste maturassero meglio. Le pannocchie erano
portate a casa con gerle e ceste, a volte col carro ed erano poste ad essiccare sui pavimenti in legno delle logge (lòse) delle case coloniche.
La
raccolta delle pannocchie e del granoturco avveniva di solito in due riprese. A
metà settembre il contadino passava nel campo e coglieva le pannocchie già
mature, cioè quelle che si erano colorate di giallo paglierino; le altre, che
conservavano ancora un colore verdastro, venivano
lasciate sullo stelo ed erano raccolte in un secondo tempo; anzi durante la prima
"passata" il contadino tagliava la parte superiore del gambo, al di
sopra delle pannocchie, affinché queste maturassero meglio. Le pannocchie erano
portate a casa con gerle e ceste, a volte col carro ed erano poste ad essiccare sui pavimenti in legno delle logge (lòse) delle case coloniche.
Nei cortili provvisti di aia, le
pannocchie venivano stese al sole a completare la
maturazione.
Ovviamente, in caso di pioggia, le
pannocchie dovevano essere immediatamente ritirate e poste al riparo, sotto i
porticati.
La sfogliatura o scartocciatura (scaossà) era fatta per lo più dopo cena
nelle lunghe serate autunnali. Al fioco lume di lanterne o di piccole lampade,
giovani e anziani, uomini e donne si raccoglievano sotto i portici (pórtèch) e procedevano
a staccare le brattee della pannocchia per mettere allo scoperto i
chicchi dorati.
Questo lavoro era accompagnato da
lieti conversari, da canti popolari e, a volte, era interrotto da brevi soste
per uno spuntino, accompagnato da vino novello.
In seguito le pannocchie venivano riunite a mazzi e appese alle balconate di legno;
con i loro colori rallegravano le tristi giornate autunnali.
Le pannocchie più belle venivano conservate per la semina della primavera
successiva.
Non si buttava niente, le foglie delle
pannocchie servivano per il pagliericcio del letto, il materasso di una volta,
e la massaia le raccoglieva con cura, le passava per ripulirle dalle scorie e
le metteva nei sacconi sui quali intere generazioni di contadini hanno passato
le loro notti. Le pannocchie dorate, rosate, rossicce e ben secche dovevano poi
essere "sgranate"; dovevano cioè essere
staccati i chicchi dai tutuli. Questo lavoro si svolgeva saltuariamente nei
ritagli di tempo nelle giornate grigie e fredde invernali, quando il maltempo
non permetteva assolutamente il lavoro in campagna. La sgranatura si faceva in
cucina accanto al fuoco o nella stalla. Il contadino teneva a fianco una gerla
di pannocchie e sulle ginocchia una cesta dove
cadevano i chicchi che si staccavano sotto la pressione delle mani con le quali
sfregava fortemente due pannocchie.
I tutuli (bianchi o rossi in base al
tipo di granoturco) liberati dai chicchi finivano nel fuoco. Il grano giallo e
dorato, ben secco veniva conservato in un luogo ben
asciutto.
All'occasione la massaia ne preparava
un sacco per il mulino.
Ne riceveva
un sacchetto di farina gialla e un sacchetto di crusca cioè le bucce dei chicchi
passati alla macinazione.
La farina veniva
messe nelle scancerie di legno (scansée)
pronta per la polenta delle settimane successive.
Termini
dialettali legati al granoturco.
Come già detto a Osio il
granoturco era chiamato melgòtt in
quanto molto simile alla melga, saggina, che veniva usata per la costruzione
delle scope.
Alcuni altri termini dialettali.
Melgàss,
melgasècc: i fusti del granoturco
senza le pannocchie. I fusti, una volta trinciati, sono destinati
all’alimentazione del bestiame o, se troppo secchi, venivano
usati come lettiera per il bestiame nella stalla..
Canù del
melgòtt: pannocchie di granoturco.
Risulì: Tutuli
sui quali sono incastonati i chicchi
Scartòss: fogliame
che ricopre la pannocchia.
Barba de canù: filamenti
che escono dalla sommità della pannocchia. In molte zone (non nella nostra) veniva usata per tisane diuretiche.
Scaössà: l’operazione
di scartoccia mento della pannocchia
Sgranà: togliere
i chicchi dau tutuli
Trincià: tagliare
a pezzetti i fusti.
La
coltivazione nella nostra zona.
Come per le altre coltivazioni, a Osio Sopra i
contadini lavoravano i terreni dei grandi proprietari terrieri in regime di
mezzadria.
La mezzadria prevedeva che tutto il raccolto e il
ricavato della vendita del bestiame dovesse essere
diviso “a mezzo” con il proprietario del terreno che solitamente era anche il
proprietario della casa in cui il contadino mezzadro (massér) abitava insieme alla sua famiglia..
Ai mezzadri era concesso di tenere, in autonomia,
gli animali domestici di piccola taglia, galline, conigli, oche ecc. ed avevano il diritto di farli razzolare sui terreni dopo i
raccolti e dopo che le contadine avevano “spigolato” cioè raccolto le spighe del
frumento o i chicchi caduti durante la raccolta.
A Osio c’erano tre latifondisti, proprietari praticamente di tutti i terreni coltivabili e non
coltivabili: Bombardieri, Stampa e Astori.
I Bombardieri erano proprietari dei terreni a Nord
del paese, l’attuale zona cave, gli Stampa erano
proprietari dei terreni ad Ovest.del paese, gli Astori possedevano tutti i terreni
a Sud-Est, praticamente oltre l’attuale autostrada e lo statale, ed alcune aree
boschive lungo il corso del Brembo.
A parte Bombardieri, che gestiva personalmente i
mezzadri che lavoravano i suoi terreni, gli altri proprietari raramente venivano
ad Osio né tantomeno si occupavano di gestire le loro
proprietà e il raccolto dei loro terreni.
La gestione era affidata, per quanto riguarda gli
Stampa ad un fattore (fatùr de Stampa), mentre, per quanto riguarda gli Astori, ad un
Capo d’uomo (Cap d’om contratto in Cald’om).
Il compito del Fattore e del Capo d’uomo era quello di verificare che il contratto di mezzadria fosse
rispettato, parlandone direttamente con i
capifamiglia e, in caso di non rispetto delle regole, segnalare la cosa
ai proprietari.
Nei rari casi di grave disaccordo, il capofamiglia e
l’intera famiglia erano allontanati: perdevano il diritto di abitare nelle stanze
occupate e di coltivare i terreni a loro assegnati.
Succedeva invece, questo molto più spesso, che al
contadino e alla sua famiglia venisse imposto di
traslocare per fare spazio a nuove famiglie che si insediavano sul nostro
territorio, in arrivo da campagne evidentemente meno produttive delle nostre.
Il trasloco veniva
effettuato, come da tradizione, il giorno 11 di Novembre, San Martino, tant’è
che, in caso di trasloco, ancora oggi si dice “fare San Martino”.
Due
parole sul granoturco di seconda coltura (quarantì).
Dopo la raccolta del frumento, che avveniva
solitamente nel mese di Giugno, sugli stessi campi veniva
seminato una specie particolare di granoturco che cresceva con grande velocità.
Il nome bergamasco di quarantì, indica appunto il fatto che nel tempo record di quaranta
giorni, più o meno verso la meà di Agosto, spuntavano
le prime pannocchie.
Purtroppo le temperature autunnali impediscono la
completa maturazione delle pannocchie. Verso la fine del mese di Ottobre, prima
dell’inizio delle prime gelate, piantine e pannocchie vengono
trinciate e insilate per l’alimentazione del bestiame durante l’inverno.

Una
bella foto scattata da Ernesto Fazioli, grande fotografo cremonese e grande testimone
della vita dei contadini lombardi.
|
Il campanile visto da Via del Pozzo |
Il campanile visto da Via Mazzini |
|
Invernici Giuseppe uno dei pionieri di Osio Sopra |
|
Regole di base per la lettura e la scrittura dei
termini dialettali bergamaschi
Nei paragrafi che
seguono, abbiamo cercato di riassumere le regole fondamentali della lettura e
della scrittura del dialetto bergamasco.
Ben lontano
dall’essere un manuale completo ed esaustivo sull’argomento, vuole essere molto
semplicemente un prontuario per la corretta pronuncia dei termini dialettali,
tenendo presente, però, che molto spesso la pronuncia varia da zona a zona e,
in qualche caso, da paese a paese.
1 – L’accento
grave (è ò) e l’accento acuto (é ó)
Le due vocali
e o, possono assumere due suoni differenti in funzione dell’accento che
le caratterizza.
In
presenza
dell’accento grave (è ò) la vocale
viene pronunciata in modo aperto mentre, con l’accento acuto (é ó), la vocale si pronuncia chiusa.
|
|
Accento grave (è ò) pronuncia
aperta |
Accento acuto (é ó) pronuncia
chiusa |
|
Esempi in italiano |
Erba,
elica, foglia, colla |
Verde,
bere, gola, ombra |
|
Esempi in bergamasco |
èrta (aperta) mèda (non sposata) mèll (guinzaglio) mòla (molle) òsta (vostra) tòr (toro) |
érda (verde) polér (pollaio) mél (miele) fónda (profonda) nóno (nonno) tór
(torre) |
2 – L ’accento tedesco ö ü (umlaut)
Per indicare
alcuni suoni che non esistono nella lingua italiana, dobbiamo fare ricorso ai
doppi puntini posti sopra le vocali o e u, cioè ö e ü.
Un ottimo
esempio della vocale “ü” è nel nome del nostro paese: Üss Sùra e un esempio di
“ö” è nel nome del paese confinante Öss Sótt .
In francese i
suoni corrispondono rispettivamente agli articoli uno
pronunciato “ön”e l’articolo una, pronunciato “ün”.
Per maggiore
chiarezza, ci si può aiutare con gli esempi sotto riportati.
|
Esempi
di ö (o umlaut) |
Esempi di ü (u umlaut) |
|
öna (una), öf (uovo), scöla (scuola), fasöl (fagiolo),
ansaröl (avanzo), bödell (budello),
cör (cuore) |
ü (uno), büs (buco), müs (muso), premüra
(fretta), altüra (altura), cünì (coniglio) |
3 – “s” sonara,
“s” sibilante e suono “z”
La
"s" quando è posta fra due vocali, può essere sonora o sibilante. La
“s” sonora si scrive come “s” singola mentra le “s” sibilante si scrive con la
doppia “s”, e viene pronunciata come una “s” singola
ma con suono più duro.
|
Esempi
di “s” sonora |
Esempi
di “s” sibilante |
|
mèsa (mezza) ciésa (chiesa) carèsa (solco profondo) pòsa (mettersi in posa) |
mèssa (messa) réssa (riccia) carèssa (carezza) póssà (riposare) |
La
"s" sonora, quando è all’inizio della parola o se viene dopo una
consonante, può essere scritta come "z" ma si pronuncia come la
"s" sonora.
Esempi:
zó (giù), zùègn (giovani), örzöl (orzaiolo),
anzaröl (avanzo).
Questa
regola vale o Osio e in tutta la bassa bergamasca dove
il suono “zeta” praticamente non esiste.
Nell’isola
(paesi compresi fra il Brembo e l’Adda), al contrario
la “s” sibilante viene pronunciata come “z” (zó, zùègn).
Per fare un altro esempio delle
differenze di pronuncia, in ValSeriana, molto spesso, la “s” sibilante è
sostituita dal suono dolce “g” (gió,
giùègn).
4 – “c” e “g”
dolci, “ch” e “gh” dure
Le consonanti
“c” e “g”, quando sono seguite dalle vocali “a”, “o” e “u” hanno un suono duro,
come nelle parole italiane: casa, corpo, cuore, galante, gondola e guscio.
Quando invece
sono seguite dalle vocali “e” e “i” hanno un suono dolce, come nelle parole
italiane: cedro, cinque, accento, bocciatura, gelso, ginepro, reggente e
loggia.
Quando sono
seguite da una consonante, a maggior ragione la consonante “h”, hanno sempre un suono duro, come nelle parole italiane:
chiesa, chiusa, perché, ghepardo e ghiotto .
Le stesse
regole valgono per la lettura e la scrittura dei termini dialettali.
La lettera
“g” in finale di parola (vedere il punto 6) ha sempre il suono duro e si
pronuncia come la “ch”
Qualche
dubbio può sorgere invece quando è la lettera “c” ad
essere posta al termine della parola, in quanto può avere suono dolce, e in
questo caso si scrive raddoppiata, o suono duro, quando viene scritta come “c”
singola.
|
“c”
finale con suono dolce |
“c”
finale con suono duro |
|
bröcc (brutti) lacc (latte) söcc (asciutt) ècc (vecchio) tècc (tetto) mórcc (morti) |
sac (sacco) pac (pacco) bosc (bosco) balöc matòc (mattacchione) lac (lago) |
Per togliere qualsiasi dubbio, molto spesso la “c” dura, in finale di parola, viene scritta come “ch”: sach, pach, bosch, balöch, matòch e lach.
5 – Il suono “s-c”
Il gruppo “sc” tanto in italiano che in bergamasco, può avere tre tipi di suono:
· Duro. Quando è seguito da “a”, “o”, “u” e da una qualsiasi consonante: scöla (scuola,) sculà (scolare), bosch (bosco)
· Palatale. Quando è seguito da “i” e da “e”, come nell’italiano sci, sciagura, lasciare. In bergamasco è un suono molto raro: sciòr e sciùra (signore e signora). Molto più spesso si usa: siòr e siùra
· Dolce. In Italiano il suono dolce è usato, all’inizio della parola, solo in caso di negazione, come ad esempio “centrato” e “scentrato”.
In dialetto bergamasco questo suono è molto più frequente e per distinguerlo, la “s” e la “c” vengono separate con un trattino: s-cèt (ragazzo, schietto), s-cèta (ragazza), mas-c (maschio), mas-cì (maschietto), brös-cia (spazzola).
6 – Finali di
parola in “d”, “v” e “g”
Le consonanti “d”, “v” e “g”, in finale di parola, si trasformano in “t”, “f” e “c”, e così vengono sempre lette anche se scritte come “d”, “v” e “g”.
Alcuni esempi:
|
proéd – proét (fare la spesa,
provvedere) öd – öt (vuoto) nüd – nüt (nudo) möd – möt (modo) |
niv – nif (neve) biv – bif (bere) növ – nöf (nove, ma anche nuovo) viv – vif – if (vivo) |
sang – sanc (sangue) fang – fanc (fango) spag – spac (spago) long – lonc (lungo) |
7 – I plurali
Alcuni plurali particolari:
|
Singolare |
Plurale |
Esempi |
|
-a |
-e |
èrbe (erbe), érde (verdi) |
|
-ca |
-che |
mosche (mosche), barche (barche) |
|
-cia |
-ce |
face (facce), |
|
-d
-t |
-cc |
nücc (nudi), gialcc (gialli), dispècc (dispetti) |
|
-ga |
-ghe |
braghe (pantaloni), maghe (maghe) |
|
-gia |
ge |
ège (vecchie), bòge (pance) |
|
-l |
-i |
animài (animali), fìi (fili), péi (peli), canài
(canali) |
|
-n |
-gn |
agn (anni), malagn (malanni) |
|
-o |
-i |
bèli (belli), fèsi (idioti o disgustosi) |
In tutti gli altri casi, i plurali sono uguali ai singolari.
Associazione Culturale “La Colombera” – gpb
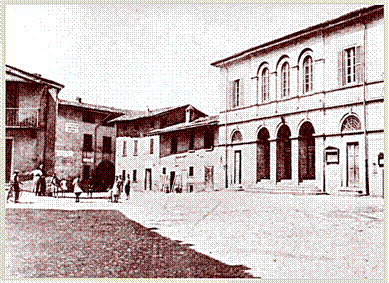
Piazza di Osio Sopra vista da Levante

Piazza di Osio Sopra vista da Ponente